Rivista di cultura filosofica
2018

Home
Monografie
Culture Desk
Ateliers
Chi siamo
Info

|
|
Fine del racconto heideggeriano
di Marco Baldino
Professionismo, settarismo, antisemitismo
Maggio 2018
Abstract
Secondo Luisa Naumann, Donatella Di Cesare, ebrea, sarebbe prevenuta, cioè una dubbia studiosa, tradita dal proprio risentimento. Secondo Alfredo Marini, Peter Trwany avrebbe “approfittato” dell’incarico di curatore per scrivere un proprio “tendenzioso” saggio interpretativo parallelo, “strumentalizzando” il testo di Heidegger e utilizzando “indegnamente” quegli “scarsi” passi relativi ad ebrei ed ebraismo, “facendo credere” “all’ingenuo lettore” che la “critica degli ebrei” fosse la pietra angolare della sua filosofia. Se, nella lettura di Heidegger, uno parte dagli ebrei è perché parte dal risentimento, dice Marini (come la Naumann). Giorgio Schira si chiede cosa vi sia mai di scabroso nell’uso del termine Judentum, senza riflettere a sufficienza sul fatto che inserendo l’essenza ebraica nella Storia dell’Essere, Heidegger traccia una corrispondenza tra “macchinazione”, “desertificazione” e quello “stigma ebraico” da cui avrebbe dovuto liberarci il movimento giunto al potere nel ’33. Ancora Marini accusa i critici di Heidegger di “idolatria dell’ente”, come dire che se uno è critico con Heidegger, di fatto si pone fuori della tradizione filosofica: non si può respingere la differenza ontologica. Evidentemente per Marini su tratta di un presupposto assoluto.
§
Nel suo articolo “L’«antisemitismo metafisico» di Heidegger è una vergogna per la filosofia italiana”, [1] Luisa Naumann non espone tesi sue, ma ripete quelle già espresse da von Herrmann e Francesco Alfieri, le quali, a rigor di termini, non sono tesi ma semplici invettive. Ecco il succo della questione: Trawny è un mezzo mascalzone; Donatella Di Cesare manca invece della necessaria serenità per giudicare, e poi è un’esperta improvvista, mentre Alessandra Iadicicco, la traduttrice italiana dei Quaderni Neri, non avrebbe esplorato a fondo lo spettro semantico di alcuni termini e, qui e là, deborda dal senso “autentico” (evidentemente quello stabilito da v. Herrmann e Alfieri) del testo heideggeriano. La Naumann aggiunge degli esempi, uno solo a dire il vero, e questo rinforzo [sic.], viene poi fatto valere come un aggravante nei confronti nei confronti di Trawny e Di Cesare. Strana procedura.
Mi chiedo: cos’è che non renderebbe serena la Di Cesare? Vorrei ingannarmi, ma temo che ciò che non rende serena la Di Cesare è né più né meno il fatto che trattasi di un’ebrea. È questo che emerge dall’articolo della Naumann, che ce l’abbia messo di proposito oppure no. Ebrea, cioè ‘prevenuta’ — non capisce, e non capisce proprio perché ebrea. La Di Cesare sarebbe cioè una dubbia studiosa tradita dal proprio risentimento. Lo stesso — lo dico con preoccupazione — filtra dall’articolo di Alfredo Marini sul Corriere del Ticino, per il quale le critiche ad Heidegger sarebbero motivate da “vedette private”. [2] Con Trawny, invece, il problema non è la comprensione, ma la cattiva volontà ermeneutica, volta a infangare un grande filosofo per attirare su di sé l’attenzione mediatica e coltivare così la propria carriera accademica. Mi par giusto ricordare che contro questa scurrilità uscita dalla penna di von Herrmann, si è levato anche Jean-Luc Nancy. Ma siccome Trawny non è italiano e non rientra perciò nel paradigma della “vergogna” stabilito dalla Naumann.
Ora, la tesi della Naumann — la più trita tesi difensiva (messa in circolazione dallo stesso Heidegger fin dal ’45) che sia mai circolata tra heideggeriani, heideggeristi e heideggerologi, di fatto non tiene il minimo conto degli sviluppi della ricerca storica (da Schneebereger e Ott in qua, fino a Faye, tanto per intenderci) — è che quello di Heidegger: a) fu un abbaglio momentaneo; b) che nel caso di Heidegger teoresi e vita non si incontrano, vanno tenute distinte, il che dovrebbe preservare la purezza della dottrina dal ripiego negativo dei comportamenti (meschini) dell’uomo-Heidegger. Il che par strano se si pensa che Heidegger ha fatto del Dasein, cioè dell’uomo impeciato nell’esistenza, il luogo autentico dell’interrogazione filosofica. La verità su tutta questa storia sarebbe pertanto contenuta nella memoria difensiva del ’45, [3] che Heidegger scrisse per la commissione d’epurazione a guerra conclusa, mentre tutto il resto sarebbe mera chiacchiera. Per fortuna il libro di Walter Homolka e Arnulf Heidegger (2016), che contiene parte almeno del carteggio di Martin con il fratello Fritz Heidegger, fa piazza pulita della barzelletta secondo cui quello di Heidegger sarebbe stato un errore breve, limitato al solo 1933. [4] Chi ha pazienza può andare a vederselo.
Ebbene, questo mix di antisemitismo dissimulato, di agiografia e di compiaciuto sfottò a carico di critici e colleghi — questo è il taglio degli articoli a dei nostri Nuamann, von Herrmann, Alfieri e Marini —, invece di essere liquidato per quello che è, pare voglia suscitare qualche seria discussione; si veda ad esempio l’articolo di Giorgio Schira, “La «scabrosa comparsa»: Judentum”. [5] E tutto ritorna nei termini di ogni esemplare tesi difensiva, i termini ‘filologici’: davvero è scabroso l’uso del termine Judentum nei Quaderni Neri? Ma quando i destinatari del discorso filosofico cessano di essere gli allievi e i colleghi del tal professore, dalla cui comunicazione è evidentemente assente ogni preoccupazione civile, allora il problema non è o non è più quello di sciorinare un sapere filologico, ma di cogliere che cosa questo o quel filosofo ci permette eventualmente di capire del nostro presente. Io mi chiedo come sia possibile non sentire la necessità di invertire l’ordine dell’interrogazione, come sia possibile non sentire che il problema non è più stabilire quanto, fin dove Heidegger si sia spinto nei rapporti con il nazismo (per altro si può ormai ritenere che Heidegger abbia scelto il nazionalsocialismo perché conveniente alla propria visione, non viceversa), ma quello di mettere a nudo il fondamento heideggeriano del “nuovo antisemitismo”, che cosa è passato del racconto heideggeriano nella visione dei contemporanei. I nuovi antisemiti sposano per esempio la tesi secondo cui non è sbagliata l’analisi heideggeriana sul ruolo del calcolo (con il calcolo non si può fare nulla, intraprendere nulla, “iniziare nulla”), ma che i nazisti si sono autoannientati, con tutta la Germania e il suo nemico ebreo, perché hanno assorbito il veleno della macchinazione tecnica e calcolatrice, che oggi si riproduce nel capitalismo globale. La globalizzazione sarebbe così il succedaneo post-nazista di americanismo, bolscevismo e ebraismo mondiale.
La stessa discussione, analizzata da Schira, intorno alla “pietra”, avviata sì da Donatella Di Cesare, secondo la quale, per Heidegger «l’ebreo è come la pietra — weltlos. Più che a-mondano, l’ebreo sarebbe addirittura im-mondo, impuro perché senza mondo, senza la mondità dell’esistenza. Riaffiora qui la pietra, metonimia, come in Hegel, della figura filosofica dell’ebreo» che Schira riprende per rovesciarla in un’arringa difensiva pro-Heidegger.
Secondo me questa discussione non fa davvero questione, perché il problema non è quanto Heidegger pensasse male degli Ebrei (pietre o uomini?), ma quanto, sulla base di Heidegger, una certa intellettualità europea si senta oggi filosoficamente spalleggiata, piena di argomenti, anzi “piena di merito”, quando, per esempio, si spinge a comporre virtuosi parallelismi tra Hitler e “Israele”. È utile qui ricordare che tra gli autori di un manifesto che paragona Israele al nazismo si possono rinvenire i nomi di Gianni Vattimo, Danilo Zolo, Costanzo Preve, Domenico Losurdo, Piero Fumarola, Margherita Hack, Edoardo Sanguineti e Franco Cardini, per non citare che i professori. [6]
A Giorgio Schira mi sento pertanto di replicare quanto segue: cosa c’è di scabroso? Beh, il fatto che Heidegger, in un contesto dove riflette sugli avvenimenti di quel suo proprio tempo, inserendoli nella Storia dell’Essere, traccia una corrispondenza secca tra “macchinazione” (alla lettera: l’incondizionato compimento dell’essere nella volontà di potenza), “desertificazione” (del mondo, svuotato di essere dalla potenza finanziario-capitalistico-tecnico-scientifica) e quello “stigma ebraico” [Judentum] da cui lo slancio verso il “nuovo inizio”, carattere peoprio del popolo tedesco, avrebbe dovuto liberarci, mentre intorno a lui, come giustamente ha ricordato Trawny, camere e forni brasavano come barbecue.
Il punto non è anzitutto — mi rivolgo qui anche a Francesca Gunella [7] — che significato emerge dal confronto di un termine con la sua occorrenza nel corpus heideggeriano. Il punto è che è filosoficamente più serio far emergere il significato di un testo, di un termine o di un intero corpus, dal confronto con il contesto storico-politico. Heidegger non è in colloquio solo con se stesso o con i grandi pensatori della storia ma, proprio lui, anche con quello che dicevano radio e giornali, con ciò che accadeva giorno per giorno dentro e fuori l’università, nelle piazze e lungo le strade, negli altri paesi europei e nel mondo. È questo che merge con prepotenza dai Quaderni Neri. Se c’è qualcosa di scabroso nel testo heideggeriano, questo non può certo emergere mettendo al lavoro un qualche dispositivo filologico o qualche approfondimento etimologico, perché Heidegger è uno che si sa difendere bene su questo terreno. Il punto è il sensus historicus: vedere bene che cosa emerge laddove le parole vanno a sbattere, quando incontrano il senso medio di cui si intesse l’esperienza quotidiana, che non è mera chiacchiera, perché i campi, ahimè, non lo erano — e la cosa più divertente è che qui possiamo persino citare il professor Marini, il quale, nel 1988, scriveva: «Tuttavia la tesi di Hannah Arendt […] che il pensiero di un autore, di un filosofo [si parlava di Heidegger, naturalmente] non debba essere messo in rapporto con la sua situazione storica, non mi convince molto». [8]
Heidegger ha fatto di tutto per rendere politicamente effettuale il proprio pensiero, non per preservarlo dall’incontro con la storia, ma per provarne la consistenza storica. Non, si badi, c’è il pensiero e poi, accanto, un certo desiderio, metascientifico, di menare le mani. In Heidegger il pensiero è intrinsecamente vocato all’effettualità politica, per liberare la quale fu necessario scendere sul terreno della lotta politico-concreta. Chi non capisce questo, non capisce Heidegger. O forse lo capisce fin troppo bene e, per questo, in quanto adepto della setta degli esperti, lo vorrebbe preservare da pericolose, e a sue dire “dilettantesche”, incursioni.
Credo ora di dover giungere due parole sull’articolo di Alfredo Marini, che qualcuno ha definito “definitorio e definitivo”. Io lo trovo invece un mero accodarsi al malcostume dell’insulto inaugurato, lasciandoci tutti basiti, da un professore tedesco così zivil come Friedrich-Wilhelm von Herrmann, inseguito da qualche giornalista in odore di post-evolismo e da qualche studioso interessato a preservare la pulizia di una carriera imperniata su Heidegger.
Marini purtroppo si associa agli insulti pronunciati da von Herrmann all’indirizzo di Trawny, anzi rincara la dose: Trawny avrebbe “approfittato” dell’incarico di curatore per scrivere un proprio “tendenzioso” [a giudizio di chi?] saggio interpretativo parallelo [congiura?]; avrebbe “strumentalizzato” [a che scopo?] il testo di Heidegger utilizzando “indegnamente” [indegnamente! Si tratta forse di lesa maestà?] quegli “scarsi” [chi stabilisce se sono scarsi oppure no: Von Herrmann? Gualdana?] passi relativi ad ebrei ed ebraismo, “facendo credere” [quindi con intenzione di raggiro] “all’ingenuo lettore” [il solito cretino] che la “critica degli ebrei” fosse la pietra angolare della sua filosofia.
Dopo di che Marini ripete l’usitato argomento dei 14 passi sulle 1250 pagine dei Quaderni Neri e riprende la desolante opinione di Herrmann Heidegger, il figlio Elfride riconosciuto da Martin, per il quale i passi incriminati sarebbero delle «Osservazioni marginali». [9] Bene! Tuttavia appare oggi evidente, per una gran schiera di critici, che, ben al di là dei 14 passi, è l’intero corpus heideggeriano a rigurgitare tutt’altra emesi, di cui i 14 passi sono semmai i torsoli non ancora sfarinati di un discorso filosofico che non prescinde, e nemmeno vuole, e forse nemmeno può, dall’antisemitismo. Mi chiedo, per esempio, perché mai Marini ignori, a bella posta debbo pensare — non si può certo sospettare il contrario, visto che abbiamo a che fare con una stimato contemporaneista — i due libri di Donatella Di Cesare. Marini si abbassa a invelenire il dibattito parlando di “vendette private” o, al più, di un anti-heideggerismo “ideologico”.
Ora, sulle cosiddette “vendette private”, vero e proprio svarione antisemita, ho già detto con riferimento all’articolo della Naumann, e mi sconcerta, ripeto, sentirlo ripetere da Alfredo Marini. Quanto all’accusa di “ideologismo”, mi fa pensare a una linea difensiva concordata o a una qualche cordata di Febroniani, avete presente? quell’eresia per cui giudici della fede “per diritto” sono soltanto gli epi-scopi e nessun pronunciamento ha valore se non è approvato da questi ispettori-custodi della “vera” dottrina. Nessuno mai, però, nel caso di dei critici dell’heideggerismo, fa cenno a quale sia quest’ideologia. Vorrei sprecare due parola su questo.
Marini, bisogna riconoscerlo, va un tantino più in là dei più sprovveduti affiliati alla setta dei febro-heideggeriani, dice che si tratta nientemeno che di “idolatria dell’ente” [sic.], come dire: l’ideologia anti-heideggeriana consiste nell’essere anti-heideggeriani. Come se il problema non fosse proprio questo: l’aver squalificato l’ente fino al ‘lerciume’, il meramente calcolato, e scomunicato chi gli sta dappresso come famulo del “calcolantismo” [mi manca l’emoticon con il sorrisino], cioè uno “tutto scienza-e-tecnica” e niente “poesia” e, quindi, nemico dell’umanità.
Sicché se uno parte dagli ebrei — dice Marini — è perché parte dal risentimento e non dall’autentico atteggiamento scientifico. Eppure qui non si parte dagli Ebrei. Uno scivolone da parte di Marini. Qui si parte dallo Judentum: il punto è il ruolo dello Judentum, cioè dell’essenza o carattere o stigma dell’ebraismo, il ruolo dell’elemento ebraico, reso ubiquo dalla diaspora, che viene interpretato come radice indiscutibile della macchinazione nichilistica che devasta l’Occidente. Il punto è che Heidegger lo interpreta appunto come un’essenza. Con Heidegger non si tratta di ebrei puri e semplici, nossignore! di enti, ma di essenze, qui siamo sul piano della Storia dell’Essere, mica sul piano della storia esistentiva, dove sporchi ebrei maneggiano i loro affarucci immondi e studentesse ebree allargano le loro intriganti coscette giudaiche per far largo al grande filosofo (Herrmann Heidegger dixit), facendogli credere, a quel falso ingenuo, che attingendo là sotto si sarebbe auto-immunizzato da ogni accusa di antisemitismo, qualunque sconcezza si fosse poi lasciato sfuggire. Nell’intento di difendere Heidegger, Davide Brullo cita la difesa d’ufficio del figlio Herrmann, il quale candidamente afferma: «“per tutta la vita Martin Heidegger intrattenne stretti legami d’amicizia, anzi strettissimi, con ebrei”. Tanto stretti che il filosofo preferiva, a letto, le ebree: Hannah Arendt ed Elisabeth Blochmann “erano amanti di mio padre; e non furono le uniche”. Nel lotto va annoverata anche l’ebrea Lily Szilasi, moglie di Wilhelm, con cui Martin intrattenne “intima amicizia” [tanto da cornificarlo]». D. Brullo, “Heidegger antisemita? Il trionfo della perversione del perbenismo”. [10]
Cosa c’entrano dunque i sei milioni di ebrei gasati nella Germania? Questa la provocazione di Alfredo Marini. E tuttavia Marini tace sul fatto che Heidegger aveva posto la Germania a guida dell’Europa nella sua insurrezione contro l’“ente” (lo ricorda Marini stesso in molti luoghi del suo lavoro accademico), la stessa Germania che ha gasato i sei milioni di ebrei; è la stessa per forza, perché è proprio Heidegger ad aver posto il nazionalsocialismo quale strumento spirituale adeguato ad esercitare il ruolo di guida. C’entrano dunque perché se è sul piano della storia esistentiva che gli ebrei-enti, mischiandosi e intrufolandosi, con la loro ributtante abilità nel far di conto, con la loro tendenza a controllare la realtà umana per mezzo del numero, è sul piano della Storia dell’Essere che diffondono il batterio virulento dell’ebraismo-essenza, ovvero la peste della macchinazione, della desertificazione, dello sradicamento, della derazzificazione, impendendo di fatto al Volk eletto di realizzare il proprio destino storico-spirituale, che consiste nel delimitare i bordi del Weg che conduce all’altro inizio.
Non è per questo che i tedeschi-enti hanno ingaggiato guerra contro gli ebrei-enti? Certo, per liberare l’Europa dalle anti-tedesche ideologie dell’Americanismo e dell’Ebraismo mondiale (le essenze perniciose si eliminano eliminando le istanze ontiche che ne praticano l’unzione — vedi Storia della colonna infame) che sono gli strumenti del controllo dell’umanità per mezzo del numero. Sarebbe dunque questa l’ideologia dei critici dell’heideggerismo? A me pare invece, tutto questo, un socratico rendersi conto della radice antisemita del pensiero di Heidegger.
[1] L. Naumann, “L’«antisemitismo metafisico» di Heidegger è una vergogna per la filosofia italiana”, Officina sedici, 22 agosto 2016.
[2] A. Marini, “Su Heidegger vendette private e finto-politiche”, Corriere del Ticino, 1 luglio 2016.
[3] M. Heidegger, “Il rettorato 1933/34” (1945), in Id., L’autoaffermazione dell’università tedesca – Il rettorato 1933/34, a cura di C. Angelino, Il Melangolo, Genova 1988.
[4] W. Homolka, A. Heidegger (edd.), Heidegger und der Antisemitismus (mit Briefen von Martin und Fritz Heidegger), Herder, Freiburg 2016.
[5] Officina sedici, 25 agosto 2016.
[6] M. Allam, Corriere.it, 4 novembre 2007. «Colpisce [inoltre] che tra i 685 nomi resi pubblici, 152 (22%) appartengono al mondo dell’istruzione, di cui 54 sono docenti universitari (8%), 35 sono docenti (5%) e 63 sono studenti (9%)».
[7] F. Gunella, “L’«autoannientamento» degli ebrei”, Officina sedici, 2 settembre 2016.
[8] A. Marini, intervento alla tavola rotonda “Il filosofo e la sua ombra”, c/o redazione Alfabeta, pubblicato sul numero 103 della rivista, dicembre 1987. Accanto a Marini si trovano gli interventi di A. Dal Lago, U. Galimberti e P.A. Rovatti.
[9] G. Dell’Arti, “L’«anima» e l’eros di Heidegger”, Il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2016.
[10] D. Brullo, “Heidegger antisemita? Il trionfo della perversione del perbenismo”, ilgiornaleoff.ilgiornale.it, 6 giugno 2016.
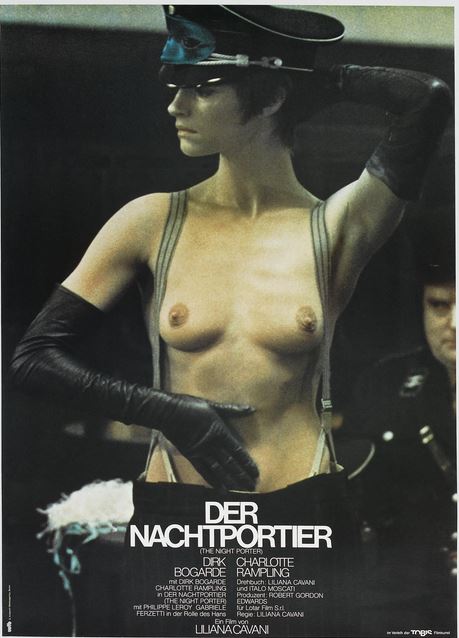
|
|

