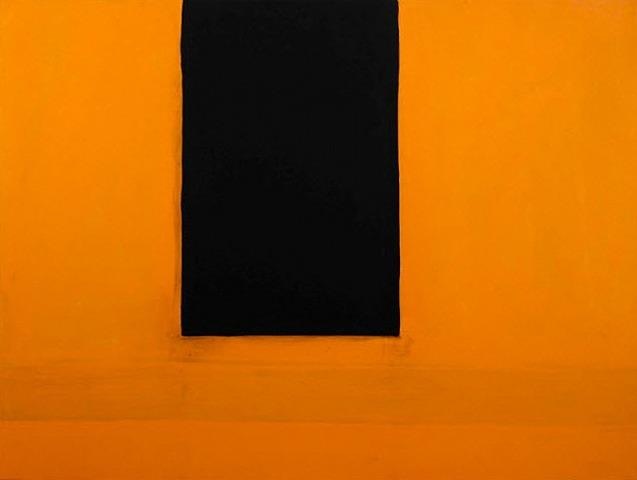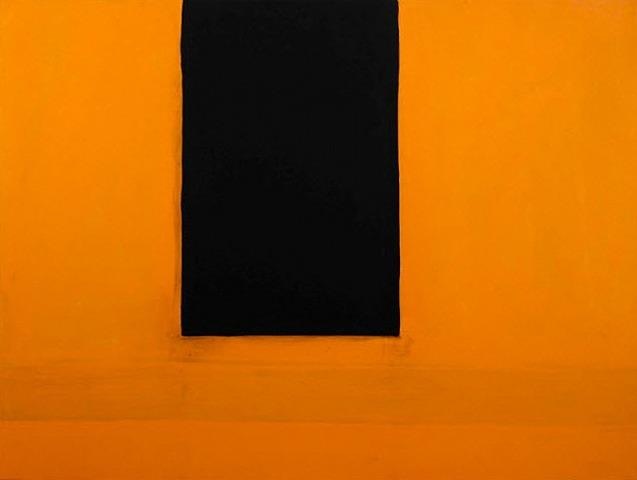Kasparhauser
2014

Rivista di cultura filosofica
Monografie
Culture Desk
Ateliers
Partnership
Chi siamo
Info
|
Archeologia del Postmoderno 2.
Etemorfologie
di Giuseppe Crivella
22 settembre 2014
Nozione complementare a Paralogia è Eteromorfia [1]. Mentre per la prima Lyotard si era attenuto a concetti desunti dall’estetica, dalla storia dell’arte, dalla psicologia della forma e dalla psicoanalisi, ora egli qui sente il bisogno di modificare ambito di interesse e si sposta nelle scienze, in particolare verso quelle nuove acquisizioni della matematica che vanno sotto il nome di Teoria delle Catastrofi e Oggetti Frattali [2].
Ma perché Lyotard compie tale fuori-campo rispetto all’ambito propriamente filosofico? Per il semplice fatto che sia Mandelbrot sia Thom coi loro studi impostano ex novo un modo di vedere e comprendere la natura in netta opposizione con la tradizione. Se da una parte infatti Mandelbrot individua dei caratteri di stabilità e dei parametri di permanenza, questi tuttavia spesso sembrano imperscrutabili o radicalmente legati al caso, in sostanza cioè la innovativa metodologia di Mandelbrot deve rinunciare a due aspetti salienti dell’epistemologia a lui precedente: descrivibilità piena del fenomeno in questione e netta predittività dello stesso. Ciò accade perché gli oggetti frattali sono delle entità frazionarie con un numero di dimensioni intermedio tra 2 e n e caratterizzati da un processo di produzione e strutturazione legato alla ricorsività omotetica riprodotta a vari gradi di miniaturizzazione [3].
Dall’altra parte René Thom si preoccupa invece di mettere a punto degli strumenti concettuali in grado di esaminare i passaggi di stato da una configurazione a un’altra: quali e quanti sono gli elementi caratteristici di una configurazione e quali e quanti devono subire una modificazione massiccia perché suddetta configurazione scivoli verso un’altra? Ecco come il grande matematico francese espone in modo molto sintetico il nocciolo duro del suo pensiero:
l’essenza della teoria classica delle catastrofi risiede nel fatto che essa mostra come un equilibrio instabile isolato di un potenziale […] possa sempre venire stabilizzato aggiungendo allo spazio iniziale […] uno spazio ausiliare (euclideo) detto «spazio di dispiegamento» [4].
In sostanza sia Mandelbrot che Thom si occupano di quello sfumatissimo e vastissimo campo di studi, problemi, ricerche che va sotto la designazione di morfologia. Va inoltre detto che i due studiosi, seppur secondo prospettive molto difformi l’uno dall’altro, avevano un “padre putativo”: il fisico D’Arcy W. Thompson, il quale nei primi anni del Novecento aveva pubblicato un saggio dal titolo On Growth and Form [5] dedicato proprio a problemi di morfologia — minerale, vegetale, animale — che poi sarebbero ripresi e ampiamente analizzati con nuove strumentazioni teoriche dai due matematici chiamati in causa da Lyotard. Ma qual è la novità introdotta da D’Arcy Thompson, Mandelbrot e Thom che tanto dovette colpire l’attenzione di Lyotard?
Grazie ai loro studi la natura piano piano stava diventando espressione di ciò che Luigi Ruggiu – in un bellissimo saggio dedicato alla Fisica d’Aristotele [6] — ha definito con l’espressione di Ontologia del Divenire, grazie alla quale l’attenzione improvvisamente è spostata dalle forme ideali, dai modelli, dagli archetipi — i quali vengono meno in Aristotele — ai processi minuti e continui che travagliano l’essere. La materia diventa protagonista, i mutamenti che essa subisce, il suo frastagliarsi in una molteplicità di eventi che affettano la forma per accidens, rendendola un fenomeno fluido, instabile, mutevole, transeunte occupano ora in modo massiccio la scena.
Non si tratta di un approdo isolato. In ambiti filosofici molto diversi tra loro nel corso del Novecento ci sono state movenze speculative affini a questa. Per fare due esempi basterà citare un passo da Jaspers, dalla sua Philosophie — siamo nella terza sezione, consacrata alla metafisica — e un brano da Deleuze, così da rendere evidente non solo l’unitarietà di un filone speculativo piuttosto penetrante nel corso del secolo breve, ma anche la varietà e la diversità d’approcci che esso ha avuto. Sentiamo come si esprime Jaspers in proposito:
La natura è l’ebbrezza del divenire. Senza domandare da dove e verso dove, la natura è l’essere nel suo infinito trascorrere, l’essere che nella sua ebbrezza si mantiene eterno. Senza conoscere né persone né destino, la natura è l’abbandono alla corrente della sua generazione, il cui incanto si intreccia col dolore di ciò che non ha senso. […] Nel suo incessante generare e distruggere, [essa] rimane indefinita e senza decisione.
[…] Essa è la forza originaria dell’anima del mondo, l’unica, grandiosa e indistruttibile vita creatrice, che, pur essendo eternamente nuova nella sua manifestazione, è sempre la stessa. Il tutto-vivente sembra che mi attragga, mi seduca, mi assorba e mi dissolva nella sua totalità vertiginosa. Le sue forme nel regno animale e vegetale sembrano rivolte a me. Ma la natura non risponde, per cui io soffro, mi riprendo e resisto, finché rimane solo un presentimento di sicurezza, un anelito verso di essa [7].
Da queste immagini di dispiega un giubilo frenetico di nascite e pulsioni autodistruttive, un divenire continuo e irrazionale, inconsapevole, equivoco agli occhi dell’uomo, ma al tempo stesso attraente. È una natura percorsa da splendori crudeli e istantanei, ove proprio la perenne istantaneità dei fenomeni che in essa si producono e si annullano ne garantisce l’inossidabile perennità, esattamente come in Aristotele. La natura — il mondo — qui assomiglia a una sorta di macchina desiderante. Ma che cos’è una macchina desiderante?
A dircelo è il secondo autore, Gilles Deleuze, esprimendosi in questi termini:
[Dans les machines désiderantes] toutes les parties sont produites comme des côtés dissymétriques, des directions brisées, des boîtes closes, des vases non communicants, des cloisonnements, où mêmes les contiguités sont des distances, et les distamces des affirmations, morceaux de puzzles différents, violemment insérés les uns dans les autres, toujours locaux et jamais spécifiques, et leurs bords discordants toujours forcés, profanés, imbriqués les uns dans les autres, avec toujours des restes [8].
Le macchine desideranti sono degli organismi-dispositivi in cui tutto funziona simultaneamente, attraverso fasci di rotture, iati, intermittenze, corto-circuiti e frazionamenti, in una sommatoria paradossale e disgiuntiva che non riunisce mai le proprie parti in un tutto. Nelle macchine desideranti i tagli sono produttivi, le disgiunzioni sono inclusive: si procede per passaggi, trasformazioni, ritorni ad uno stesso che non finisce di configurarsi se non attraverso lo sparpagliamento delle proprie disiecta membra. In esse bisogna pensare per frammenti che strutturano rapporti obliqui tra differenze orfane d’ogni referenza a una totalità originaria. Si tratta di una molteplicità intensiva, eterogenea, accrescitiva per dissipazione e non evolutiva, aggettivale-sostantiva e non predicativa: a proliferare sono le caratteristiche della macchina, i suoi attributi aberranti e deformanti: in essa si procede per accostamenti di parti dissimetriche, direzioni infrante, vasi comunicanti che si raccordano mediante delle contiguità a distanza, perché imbricati l’uno nell’altro a costituire un universo di scarti e dispersioni in un mondo polifonico e trasfinito fatto di esplosioni, rotazioni, vibrazioni.
Alla luce di quanto detto tenteremo di illustrare in quanto segue tre esempi di eteromorfie desunti da altrettanti autori della tradizione filosofico-letteraria occidentale, al fine di mostrare come essa da una parte affondi le sue riposte radici in un terreno per lungo tempo ininvestigato, dall’altra si ramifichi in una serie di analisi, riflessioni, concettualizzazioni e nozioni che tuttora occupano il centro del dibattito speculativo internazionale.
Canetti, le corps morcelé
Partiamo da Elias Canetti e dal suo monumentale studio del 1960 dal titolo Masse und Macht. Siamo al paragrafo quattro del nono capitolo: Massa e metamorfosi nel Delirium tremens; l’autore sta parlando delle percezioni aberranti che il soggetto psicotico avverte tramite tutto il suo organismo e si esprime in questi termini, citando Kräpelin:
molteplici, singolari sensazioni della pelle fanno sorgere nel malato l’idea che si muovano lungo tutto il suo corpo formiche, rospi, ragni...Egli si sente avviluppato da sottili fili, schizzato d’acqua, morsicato, punto, colpito. Il malato raccoglie le monete che vede in gran numero intorno a sé, le sente chiaramente nella mano, ma esse scivolano via come argento vivo. Ciò che egli afferra svanisce, striscia, oppure cresce enormemente per tornare poi a dissolversi, a rotolare via, a scorrere lontano... I piccoli nodi e le irregolarità del tessuto sembrano pulci sulle lenzuola, le scalfitture dei piatti sembrano aghi; nelle pareti si aprono porte segrete [9].
E ancora, passando in rassegna le allucinazioni tattili e visive dell’alcolizzato, Canetti prosegue notando:
il bevitore […] s’immagina che migliaia di […] animaletti percorrano la sua pelle. Essi invadono il suo corpo in grandi eserciti; poiché sente su di sé i loro movimenti, il malato tende a vederli dappertutto. Li trova ovunque stenda la mano; il suolo ai suoi piedi e l’aria intorno a lui sono pieni di tutto ciò che al tatto si rivela molteplice.
Questa sensazione di massa della pelle, come la si potrebbe chiamare, ci è nota non soltanto nel delirio [10].
La metamorfosi dilania irreparabilmente la psiche del malato: da una parte vi è un relitto macroscopico di ego iperconsapevole e ancora funzionante che vede tutto, sente tutto, avverte tutto, funge cioè da polo catalizzatore degli eventi minimi che tempestano il suo corpo. Dall’altro lato vi è questo corpo che è la trascrizione disordinata ma puntuale di movimenti, scatti, corse, morsi. Un corpo fatto di corpi; un corpo di corpi in agitazione e gravitazione, in tensione, un corpo che è campo di pulsioni reciprocamente aggressive e di conati falliti ma insistenti per uscire da esso. Un corpo schizofrenico di corpi in dissidio. Un corpo profondamente dimidiato anche nella forma: compaiono alle sue estremità delle mani-ratto, dei piedi-ragno, delle dita-formiche; la pelle è un pullulare di insetti, elitre, zampe ed ali che lo travagliano di punture, fremiti, graffi, pruriti, mandibole microscopiche che lo feriscono senza lacerarlo.
La metamorfosi qui ha una struttura lenticolare e disorganica; ma è tale perché vi è ancora un ego spettatore di tutto ciò. E l’ego è spettatore di tutto ciò perché esso è attraversato da un’inesauribile e dilaniante formazione di compromesso tra due tendenze opposte: dal lato vi è nel malato un desiderio di autodistruzione, di autodisfacimento; ma vi è anche un senso di misconoscimento della propria identità qualificata proprio da quello stesso corpo. Ma dall’altro lato vi è un desiderio simmetrico e inverso: espellere tali creature aliene per ricompattarsi nel proprio corpo. Il corpo e la psiche qui sono macchine desideranti tanto più efficienti quanto più disfunzionali; ma qui tuttavia non abbiamo la riduzione — o la regressione — dell’uomo a strati primitivi dell’organico. Qui abbiamo un netto superamento dell’uomo e dell’umano, il suo frastagliarsi in una serie di ipotesi organiche che fino ad allora l’unità fisiologica “uomo” aveva negato, soppresso, soffocato o disinnescato. Esso insomma è una macchina desiderante in cui d’improvviso si risvegliano delle virtualità morfologiche autonome e parassitarie che cercano di emanciparsi da esso, tramutandolo in una sorta di terra incognita dove manifestazioni aberranti di generatio aequivoca allignano senza requie.
Il desiderio pertanto non dipende dall’estrinsecarsi di una volontà unitaria e compatta, ma piuttosto si disgrega in una serie convulsa di volizioni slegate e conflittuali, in una ressa anonima e pre-soggettiva di pulsioni e trazioni fisiologiche, le quali non solo non possono essere soddisfatte — esse esistono solo in quanto esiste l’apparato generale in seno al quale maturano — ma non possono essere neppure disinnescate. Il corpo del malato presentatoci da Canetti è una distesa fermentante di proiezioni neuro-vegetative che trasversalmente toccano tutti i campi del vitale (e non solo). La macchina desiderante è dunque satura di potenzialità aberranti e dissipative. Cedevole e molle come un terreno fangoso, il corpo del malato è un ininterrotto pulsare di contrazioni sismiche che invece di dilaniarlo sembrano compaginarlo in una sussultoria geologia di forme appena accennate e subito sfumate, in una coreografia straziante e straziata di ipotesi organiche che per brevissimi e lancinanti istanti si profilano ai suoi bordi trasformandole in una selvaggia euforia, nel cui stratificato accumulo di figure e strutture volubili la sfera dell’umano è terribilmente prossima a quella del protozoo sovradimensionato in proporzioni mostruose.
Ma soffermiamoci un attimo sulla natura degli animali elencati nel passo riportato poco sopra: si tratta per lo più di insetti e roditori, creature dalla morfologia tremendamente remota da quella del corpo dal quale emergono, esseri striscianti, repellenti, aggressivi e coriacei. Essi scavano, graffiano, pungono, mordono, rodono, s’intrufolano, scivolano tra gli oggetti, invisibili e molesti, sono presenze felpate ma ingombranti, in ogni modo infestanti. In tal senso il corpo del malato diventa un teatro ricco di agitate figure informi e sfuggenti, che occupano rapidamente il centro della scena scatenando nell’uomo il senso di una sordida possessione animale, da cui non c’è scampo. Tra la dissoluzione del malato in un fitto brulicare di organismi solo abbozzati, ma repellenti e voraci, e la conservazione del corpo adibito a proteiforme terreno di incubazione, il soggetto diventa un vischioso coacervo di mutile e mucose trame (de)generative, di corrotte e devianti germinazioni, nel cui livido profluvio tutto un bestiario para-umano viene ad inserirsi con la cupa e contorta nidazione di un abominio labirintico e inesaurito, stratificato lungo le crepate placche telluriche di una coscienza perversamente lasciata a macerare nel suo stesso humus cellulare.
Ma vi è anche un altro aspetto molto interessante nell’estratto di Canetti che richiede di essere messo in luce: in esso troviamo uno di quei rari casi in cui la differenziazione endogena delle parti di un organismo non porta ordine nella distribuzione delle funzioni, ma piuttosto sconvolgimento, caos, distruzione. L’animalizzazione del corpo del malato fa sì che la natura diventi una potenza astratta di metamorfosi, le quali non seguono una linea evolutiva connessa e coerente, ma piuttosto strutturata per salti morfologici, biologici e zoologici.
Il vivente in questo caso è visto come una infinita sorgente aconcettuale di scissioni del sé entro sé, una febbrile autorelazione di stadi organici reciprocamente escludentisi. Siamo pertanto sempre sull’orlo di ciò che Hegel nella sua Enzyklopädie [11] definisce come Form im Erzittern [12], ovvero un’oscillazione persistente e insistita tra negazione e sussistenza della coesione delle parti, una vibrazione diffusa e virulenta, la quale altera il rapporto tra le membra senza però riuscire a portare alla evaporazione del tutto, un’alternanza senza sbocco o fine tra la dilatazione di materiali incoerenti — che rendono il corpo fragile come vetro — e la latenza di una unità sepolta — la quale divampa solo quando rischia d’andare definitivamente perduta. Puntiforme e transitoria, l’identità del malato non riesce a chiudersi sulla propria ipseità, così che una vitalità aberrante esplode in essa polverizzandosi in formazioni che pulsano e circolano verso compenetrazione disgiuntiva d’anatomie dismorfiche.
Ovidio, modulations
[...] Coepere virescere telae
inquae haederae faciem pendens frondescere vestis;
pars abit in vites et, quae modo fila fuerunt,
palmite mutantur; de stamine pampinus exit;
purpura fulgorem pictis adcommodat uvis.
Iamque dies exactus art per tempusque subibat,
quod tu nec tenebras nec posses dicere lucem,
sed cum luce tamen dubiae confinia noctis:
tecta repente quati pinguesque ardere videntur
lampades et rutilis conlucere ignibus aedes
falsaque saevarum simulacra ululare ferrarum.
Fumida iamdudum latitant per tecta sorores
diversaeque locis ignes ac lumina vitant,
dumque petunt tenebras, parvos membrana per artus,
porrigitur tenuique includunt bracchia penna;
nec, que perdiderint veterem ratione figuram,
scire sinunt tenebrae [13].
(Ovidio, Metamorfosi, IV, vv. 394-411)
Probabilmente poche opere della nostra tradizione letteraria possono essere elevate legittimamente ad esempi sommi di ciò che nelle catalogazioni retoriche dell’antichità veniva designato col termine di enargheia (o ipotiposi), coll’intenzione di indicare una congestionata evidenza descrittiva, un gusto che oggi derubricheremmo come quasi fiammingo nella riproposizione dei dettagli materiali che costellano la vicenda. Senza scendere troppo nello specifico possiamo notare che nel poeta di Sulmona sovente si riscontrano due caratteristiche tipiche di molta letteratura (post)moderna [14]:
1. La trasformazione della pausa descrittiva in una vibrante propulsione narrativa che coglie il fatto riferito secondo una omogenea e coerente scomposizione capillare.
2. La cura per il dettaglio minimo che viene focalizzato ad altissima risoluzione.
Lo sviluppo delle Metamorfosi ovidiane si compone di continue soste narrative che interrompono un primo livello esegetico per farvi fiorire all’interno una serie di strati microscopici di scandagli e affondi descrittivi, a volte apparentemente senza nesso diretto col livello in seno al quale si schiudono. È metamorfica, potremmo dire, la narrazione stessa delle Metamorfosi, e non è pertanto un caso il fatto che proprio Ovidio nei versi iniziali della sua opera parli di essa come di Carmen perpetuum.
Nel caso specifico — siamo nel IV libro, in presenza dell’episodio immediatamente successivo a quello di Salmacide e Ermafrodito, avente per protagoniste le figlie di Minia mutate per colpa della loro empietà in pipistrelli – la metamorfosi irrompe con una certa asprezza. In primis essa stessa è inquadrata da una serie di trasformazioni accessorie: la crepuscolarità del momento del giorno, i telai che diventano viti, lingue di fuoco che arrivano da tutte le parti; ma la metamorfosi centrale è invisibile: entra nella scena dall’interno dei corpi stessi delle figlie di Minia. Mentre queste fuggono la loro pelle si tramuta in piume e una sottile ma tenace membrana nera le avvolge interamente; esse iniziano così ad emettere degli stridori assordanti al posto delle parole. La metamorfosi qui è una dimensione perfusiva, si insinua ovunque, sfuggente ma letale, non lascia scampo a nulla alterando col suo tocco leggero e demoniaco corpi e oggetti, suoni e forme, organismi vegetali e presenze inanimate. Due pertanto sono i caratteri specifici della metamorfosi ovidiana:
A) Essa è analitica e coerente: passa in rassegna tutta la figura umana e permea di sé ogni aspetto della natura. La metamorfosi coinvolge tutti gli elementi della scena, non lascia fuori nulla.
B) Essa è sempre risolutiva di uno stato di tensione; ha proprietà omeostatiche, interviene per placare uno scompenso all’interno di una situazione altrimenti senza via d’uscita; punisce la ubris, ma permette anche una sorta di riparazione all’interno dell’economia generale dell’universo, spesso ammantandosi di pietà; castiga desideri eccessivi o profanatori ricomponendo in uno stato di equilibrio le forze in gioco.
Anche in questo caso dunque la metamorfosi funziona come una macchina desiderante. Ma una macchina desiderante che non procede per frazionamenti epigenetici, ma per modulazioni. Arriviamo così ad un concetto centrale per la narrativa del Novecento, quello appunto di modulation. È ancora una volta a Deleuze che dobbiamo rifarci per capire cosa debba intendersi con esso; leggiamo pertanto un passo del suo saggio del 1988 dedicato al Barocco e intitolato La piega, nel quale il teorico del pensiero nomade affronta il nuovo statuto dell’oggetto, nel momento in cui la fluttuazione di una norma subentra al permanere di una legge, facendo sì che ogni cosa s’inserisca in un continuum per variazione:
il nuovo statuto dell’oggetto non lo ricollega a un modello spaziale, cioè a un rapporto forma-materia, ma a una modulazione […] che implica una messa in variazione continua della materia come uno sviluppo continuo della forma. Nella modulazione non esiste mai una sosta per la sformatura continua; un modulatore è un modello [...] continuo. Modellare equivale a modulare in modo definitivo, modulare equivale a modellare in modo continuo e perennemente variabile [15].
L’enargheia quindi è un dispositivo che funziona a doppio regime: se da una parte essa arresta risolutamente l’evoluzione della trama nei suoi sviluppi macroscopici, dall’altra questa permette una micrologia sottile e precisa, la quale arricchisce indirettamente la vicenda generale tramite un approfondimento e un ampliamento degli elementi accessori i quali, seppur a volte possono sembrare estrinseci od episodici, in realtà costituiscono un rafforzamento tematico non di scarso rilievo o pertinenza.
Torniamo un attimo alla mutazione delle figlie di Minia: sebbene questa sia una delle metamorfosi più compendiarie e avara di particolari minutamente descrittivi, il frangente oscuro e e brillante della trasformazione è trattato con una sofisticatissima strumentazione stilistica che permette di smontare la ripida sequenza in due segmenti principali e, all’interno di questi sezionare la tortuosa logica della metamorfosi: innanzitutto la confusa commistione tra luce e buio, gli incerti confini tra giorno e notte, quali frontiere sensibili di una transizione sospetta ed anomala, indicano già la sospensione brutale e insanabile di una legge universale, sospensione che ha il ruolo palese di introdurre e quasi evocare oscuramente l’episodio delle figlie di Minia, anche attraverso la veloce notazione riguardante le false immagini delle belve selvatiche.
Abbiamo allora una sorta di trasparente chiasma rappresentativo: nel momento in cui si produce un arresto inspiegabile del tempo, le immagini false degli animali in realtà raffigurano le effigi effettive delle figlie di Minia, là dove queste appaiono sempre più quali immagini fugaci prossime ad essere smesse tramutandosi in ingannevoli simulacri per lasciare il posto alle fattezze che eternamente prenderanno le fanciulle. L’enargheia pertanto lavora in questo brano non tanto ricorrendo a una notevole profusione di dati, ma piuttosto elaborando una vasta e avvolgente matrice occulta di richiami, equivalenze, orchestrazioni a distanza, così da sfumare il processo della metamorfosi rendendolo una specie di nucleo pulsante in ogni punto dell’episodio, seppur irreperibile di fatto in un luogo preciso e identificabile.
Dinanzi a tale mutazione la ragione è impotente, disarmata, smarrita: essa è però perfettamente metaforizzata in quel rosso fulgore che divampa un attimo prima della trasformazione illuminando simultaneamente, quasi a creare una rarefattissima crasi figurale, le false immagini nella loro dura fissità e il movimento rapinoso e vano delle donne; e, nonostante ciò, nel momento in cui questi due aspetti vengono a fondersi e a sovrapporsi ogni sforzo, ogni tentativo, ogni pretesa di comprendere e di vedere è immediatamente annichilito, bloccato, dissolto: «nec qua perdiderint veterem rationem figuram,/ scire sinunt tenebrae».
Con Ovidio siamo di fronte ad una fenomenologia lacunosa e travagliata, quasi una fenomenologia dell’irrappresentabile, una sorta di controversa icnografia, ovvero una leggera nebulosa di tracce sparse e incoerenti. Ovidio sa benissimo che per quanto lo sguardo sul reale possa essere ravvicinato ed attento, questo in ultimo non potrà non tramutarsi in «concrezione di spuma nelle divine profondità», come viene definita la stessa Venere sempre nel V libro, qualche pagina dopo l’episodio da noi riportato.
Pertanto è proprio l’analiticità della descrizione ad esprimere e veicolare lo scacco e il fallimento delle istanze rigorosamente esplicative e comprensive di una ragione solida e poderosa. Questa è sostituita da una ragione volatile: essa non spiega, non dimostra seguendo i parametri logici di una razionalizzazione che asfissierebbe il mito. Narra con dovizia di particolari, mostra, riporta con una pregnanza figurativa che non troviamo presso altri autori contemporanei o successivi a Ovidio. Questo non è Platone e non vuole esserlo. La sua è una ratio narrativa, espositiva e non esplicativa. Ratifica stati di fatto o ipotesi su di esse, ma non ne propone mai una spiegazione definitiva. Tutto è semplicemente vicissitudine e forma, per dirla con Luzi. Letta in questo senso l’eteromorfia lyotardiana consuona perfettamente con un passo centrale della terza critica kantiana: si tratta di un passo del paragrafo 49 del secondo libro; qui il filosofo di Königsberg sta affrontando il sublime dinamico della natura e, nello specifico, è arrivato a parlare della deduzione dei giudizi estetici puri. In questo contesto egli nota che
se si sottopone ad un concetto una rappresentazione dell’immaginazione, che appartenga alla sua esibizione, ma che per se stessa dia tanta occasione a pensare da non lasciarsi mai racchiudere da un concetto determinato, e quindi estenda esteticamente il concetto in un modo illimitato, l’immaginazione è in tal caso creatrice [schöpferisch], e pone in moto la facoltà delle idee intellettuali (la ragione), facendola così pensare, all’occasione di una rappresentazione […], più di quanto in essa possa essere compreso e pensato chiaramente [16].
Letta in questo senso la metamorfosi incarna compiutamente quello slancio dell’immaginazione (der Einbildungskraft Schwung) tipico delle idee estetiche, le quali in tal maniera vivificano l’animo, aprendogli la vista su un campo smisurato di rappresentazioni. Sebbene allora le trasformazioni si susseguano in modo disordinato e felice, in un caleidoscopio di forme e figure che non hanno tregua, ognuna di esse è limite e soglia: chiude un episodio ma ne apre innumerevoli altri, all’interno di un albero narrativo ricchissimo e inarginabile, che conduce necessariamente la materia in gioco oltre-l’umano. Ma perché oltre l’umano? Per il semplice fatto che pensare il mondo anchilosato nelle sue parvenze immutabili, fisse, eterne è una presunzione umana, troppo umana. Non è un caso che le metamorfosi ovidiane si concludano prospettando una desertificazione al tempo stesso senile e aurorale, in ogni caso ove sia espunta la presenza umana.
Ma è proprio così? In effetti una presenza umana c’è ed è quella del poeta stesso.
A distanza di secoli troveremo la stessa immagine, lo stesso panorama scheletrico del mondo ove pare sia assente ogni traccia umana. Ma all’improvviso questa affiora e si afferma con potenza e pregnanza. Si tratta del frammento 1067 del Wille zur Macht nietzscheano, scritto probabilmente nel 1885 e solo nell’ultimo progetto lasciatoci dall’autore posto come tonante epilogo alla sua opera destinata non solo a rimanere incompiuta ma anche a suscitare le più feroci polemiche filologico-esegetiche. Per il momento quest’ultimo aspetto non ci riguarda, quindi limitiamoci a leggere brevemente suddetto passaggio:
E sapete voi che cos’è per me il mondo? Devo mostrarvelo nel mio specchio? Questo mondo è un mostro di forza, senza principio, senza fine, una quantità di energia fissa e bronzea, che non diventa né più grande né più piccola, che non si consuma ma solo si trasforma, che nella sua totalità è una grandezza invariabile, un’economia senza profitti né perdite, ma anche senza incremento, senza entrate, circondata dal nulla come dal suo limite; non svanisce né si sperpera, non è infinitamente esteso, ma inserito come un’energia determinata in uno spazio determinato, e non in uno spazio che in qualche punto sia “vuoto”, ma che è dappertutto pieno di forze, un gioco di forze, di onde di energia che è insieme uno e molteplice, di forze che si accumulano e là diminuiscono, un mare di forze che fluiscono e si agitano in se stesse, in eterna trasformazione […]. Questo mio mondo dionisiaco che si crea eternamente, che distrugge eternamente se stesso, questo mondo misterioso di voluttà ancipiti, questo mio “al di là del bene e del male”, senza scopo, a meno che non si trovi uno scopo nella felicità del ciclo senza volontà, a meno che un anello non dimostri una buona volontà verso di sé — per questo mondo volete un nome? Una soluzione per tutti i suoi enigmi? E una luce anche per voi, i più nascosti, i più forti, i più impavidi, o uomini della mezzanotte? [17]
Ecco, vogliamo fermarci su questa immagine: gli uomini della mezzanotte. Uomini del trapasso e nel trapasso, uomini della transizione e nella transizione epocale, tra due momenti storici. Uomini crepuscolari che interrogano silenziosamente il discrimen indistinto e inavvertito — ma comunque presente — tra due tempi. Gli uomini della mezzanotte sono coloro che attendono e vegliano; ma mentre vegliano pensano, riflettono, sognano e progettano l’epoca successiva, sono impegnati a ruminarla.
Gli uomini della mezzanotte probabilmente siamo noi, noi postmoderni; siamo noi che assistiamo a uno spettacolo di cui facciamo parte. Ma noi non siamo semplicemente gli spettatori del postmoderno, ne siamo gli attori. Questo spettacolo non tollera opinioni, ma esige azioni e interpretazioni sugli stati possibili, interpretazioni dettate da un approccio metodologico micrologico e analitico in grado di supportare una profondità di sguardo e una penetrazione conoscitiva basata su una dimensione critica e autocritica capace di operare un continuo aggiornamento e riassestamento del disegno ermeneutico proposto.
Qualche decennio prima che Nietzsche scrivesse queste pagine un altro grande filosofo aveva sottolineato come chaque époque rêve la suivante [18]: sognarono le epoche successive Esiodo e Aristotele, Ovidio e Averroè, Dante e Giordano Bruno, Cervantes e Tesauro, Sterne e Kant, Flaubert e Mallarmé, Eliot e Musil. Tutti uomini della mezzanotte che hanno progettato e inventato il tempo a venire, immaginandolo attraverso i sogni che offrivano loro l’arte e le scienze, la letteratura e la filosofia. Ed è forse questo il compito che oggi tocca a noi espletare, noi uomini della mezzanotte, noi postmoderni.
[1] J.-F. Lyotard, La condizione Postmoderna. Rapporto sul sapere, a cura di C. Formenti, Feltrinelli, Milano, 1981, p. 116.
[2] Ivi, p. 117.
[3] B. Mandelbrot, Gli oggetti frattali, a cura di R. Pignoni, Einaudi, Torino, 2000.
[4] AA.VV., Goethe scienziato, a cura di G. Giorello e A. Grieco, Einaudi, Torino, 2005. Nello specifico cfr. l'intervento di R. Thom, Goethe e la pregnanza delle origini, p. 267.
[5] D'Arcy W. Thompson, Crescita e forma, a cura di J.T. Bonner, Bollati Boringhieri, Milano, 1993.
[6] Aristotele, Fisica, trad. it. L. Ruggiu, Mimesis, Milano, 2005, p. 36.
[7] K. Jaspers, Filosofia, a cura di U. Galimberti, Mursia, Milano, 1978, p. 1119.
[8] G. Deleuze, F. Guattari, L'anti-Oedipe, ed. de Minuit, Paris, 1972, p. 32.
[9] E. Canetti, Massa e potere, trad. it. di F. Jesi, Adelphi, Milano, 1988, p. 435. Cfr. inoltre G. Deleuze, F. Guattari, Mille Plateaux, ed. de Minuit, Paris, 1980, pp. 46-47.
[10] Ivi, p. 437.
[11] G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, ed. it. a cura di Vincenzo Cicero, Bompiani, Milano, 2007.
[12] Ivi, p. 512.
[13] Ovidio, Metamorfosi, a cura di A. Perutello, Einaudi, Torino, 2000, p. 167.
[14] In proposito cfr. R. Barilli, Robbe-Grillet e il romanzo postmoderno, Feltrinelli, Milano, 1988.
[15] G. Deleuze, La piega, a cura di D. Tarizzo, Einaudi, Torino, 2004, p. 28.
[16] I. Kant, Critica del giudizio, trad. it. di A. Gargiulo, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 307.
[17] F.W. Nietzsche, La volontà di potenza, a cura di P. Kobau e M. Ferraris, Bompiani, Milano, 2008, pp. 561-562.
[18] Cit. in W. Benjamin, Angelus Novus, ed. it. a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino, 1977, p. 167.

Lipko
|
|
|
|
|